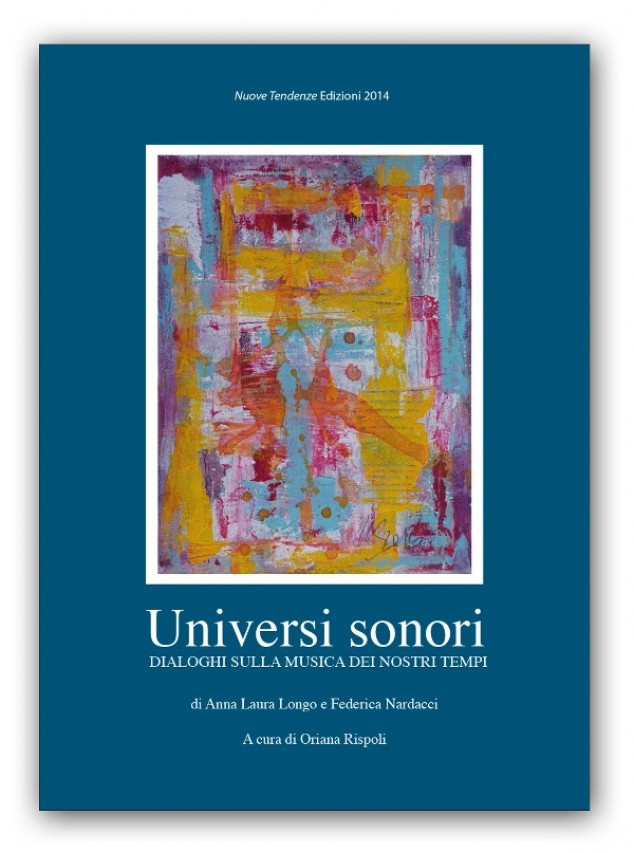 Universi sonori di Anna Laura Longo e Federica Nardacci raccoglie interessanti conversazioni con alcuni musicisti e compositori di varia tendenza e provenienti dalle più diverse esperienze. Nelle interviste si racconta il retroterra dei singoli artisti, se ne dipana il percorso e si affrontano soprattutto alcuni nodi fondamentali del fare e pensare la musica oggi nella perpetua tensione tra tradizione e innovazione, due poli tra i quali ogni artista si muove e che non è possibile ignorare. Senza dimenticare l’importanza del pubblico, il cui ruolo è probabilmente stato sottovalutato per troppo tempo dalle esperienze di avanguardia (e, talora, con errore opposto e coincidente, umiliato in certe esperienze musicali di sfrontata ed assoluta semplicità e banalità). Proprio la pluralità di approcci, beninteso all’interno di una certa idea di musica per l’oggi, è la caratteristica più interessante del libro. Non a caso il titolo non rimanda alla singolarità un po’ stuporosa e un po’ mistica dell’“universo sonoro” al singolare, con il suo carico di tradizione radicata (da Pitagora e Plotino fino a Tolomeo e Keplero – passando dalle mirabili fantasticherie di Kircher), ma ai plurali universi, ognuno con la sua coerenza interna ma ricco di novità.
Universi sonori di Anna Laura Longo e Federica Nardacci raccoglie interessanti conversazioni con alcuni musicisti e compositori di varia tendenza e provenienti dalle più diverse esperienze. Nelle interviste si racconta il retroterra dei singoli artisti, se ne dipana il percorso e si affrontano soprattutto alcuni nodi fondamentali del fare e pensare la musica oggi nella perpetua tensione tra tradizione e innovazione, due poli tra i quali ogni artista si muove e che non è possibile ignorare. Senza dimenticare l’importanza del pubblico, il cui ruolo è probabilmente stato sottovalutato per troppo tempo dalle esperienze di avanguardia (e, talora, con errore opposto e coincidente, umiliato in certe esperienze musicali di sfrontata ed assoluta semplicità e banalità). Proprio la pluralità di approcci, beninteso all’interno di una certa idea di musica per l’oggi, è la caratteristica più interessante del libro. Non a caso il titolo non rimanda alla singolarità un po’ stuporosa e un po’ mistica dell’“universo sonoro” al singolare, con il suo carico di tradizione radicata (da Pitagora e Plotino fino a Tolomeo e Keplero – passando dalle mirabili fantasticherie di Kircher), ma ai plurali universi, ognuno con la sua coerenza interna ma ricco di novità.
È evidente come la maggior preoccupazione delle autrici non sia quella di esaurire il discorso attorno ad alcune questioni fondamentali, quanto piuttosto l’urgenza di stimolare un discorso vasto e ininterrotto, di fornire chiavi di lettura per un lavoro collettivo che se vuole sopravvivere deve accogliere una mentalità pluralistica e aperta all’altro. Senza contare che (è un triste ritornello ma è purtroppo anche la verità) la quasi totalità delle esperienze contemporanee in fatto di musica di ricerca è sepolta, non ottiene visibilità per l’ostracismo dei canali di comunicazione e un perverso meccanismo di debolezza economica (fare arte costa, certo, ma non quanto gli organizzatori talvolta vorrebbero – chiamandosi fuori – farci credere).
 Proprio al tema dell’”accoglienza”, vengono dedicate molte riflessioni, già a partire dalla prima intervista con Federico Costanza e intitolata Quando ascoltare vuol dire “farsi capienti”. Ogni volta che ci si pone (o si viene posti) davanti a una novità in campo artistico c’è un istintivo moto di rifiuto a causa della novità, che rischia di mettere in gioco le nostre certezze (anzi, in qualche misura deve farlo). Ecco allora che predisporsi ad abbattere le barriere dell’abitudine e della comodità, e spesso della vigliaccheria intellettuale, aprendosi piuttosto ad una pur temporanea fase di incertezza, può essere la chiave per abbandonarsi a quelli che sono non solo (se “solo” si può dire) nuovi linguaggi musicali, ma addirittura radicali stravolgimenti del modo di intendere il suono stesso. Difficile, infatti, far passare al pubblico le sperimentazioni sul suono quando musiche certo straordinarie ma che si esprimono in un linguaggio (mi auguro di non venire frainteso!) tutto sommato tradizionale (l’esempio più ovvio potrebbe essere Le Sacre du printemps) vengono accolte come difficile musica contemporanea anche quando… hanno compiuto il secolo di vita!
Proprio al tema dell’”accoglienza”, vengono dedicate molte riflessioni, già a partire dalla prima intervista con Federico Costanza e intitolata Quando ascoltare vuol dire “farsi capienti”. Ogni volta che ci si pone (o si viene posti) davanti a una novità in campo artistico c’è un istintivo moto di rifiuto a causa della novità, che rischia di mettere in gioco le nostre certezze (anzi, in qualche misura deve farlo). Ecco allora che predisporsi ad abbattere le barriere dell’abitudine e della comodità, e spesso della vigliaccheria intellettuale, aprendosi piuttosto ad una pur temporanea fase di incertezza, può essere la chiave per abbandonarsi a quelli che sono non solo (se “solo” si può dire) nuovi linguaggi musicali, ma addirittura radicali stravolgimenti del modo di intendere il suono stesso. Difficile, infatti, far passare al pubblico le sperimentazioni sul suono quando musiche certo straordinarie ma che si esprimono in un linguaggio (mi auguro di non venire frainteso!) tutto sommato tradizionale (l’esempio più ovvio potrebbe essere Le Sacre du printemps) vengono accolte come difficile musica contemporanea anche quando… hanno compiuto il secolo di vita!
Mi sembra infatti vitale smettere di pensare la musica come una serie di dominii, nei quali chi comanda per un certo periodo fa tabula rasa del passato. Schoenberg è morto: bisogna allora piantare la propria bandiera nel mondo musicale e decidere di essere gli unici nel giusto, i depositari della verità in musica? Resterà chi (come ad esempio Berio) pensava la musica come un percorso ininterrotto che deve sempre fare i conti con il passato, oppure certi bombaroli dimenticati o quasi appena il loro potere nel mondo dei concerti e dell’editoria è svanito? Ogni arte dovrebbe mettersi nel solco del passato e poi guardare continuamente fuori, fino a quando ritiene opportuno, con uno sguardo finalmente consapevole e quindi davvero libero, tentare nuove vie.
Altra nozione chiave in Universi sonori è non a caso quella della “veridicità” del suono (si veda soprattutto l’intervista con Silvia Lanzalone): occorre andare alla ricerca della natura essenziale del suono, liberato da ogni costrizione e sovrastruttura. Ogni compositore cercherà questo disvelamento a suo modo, e i modi sono infiniti, ci viene ricordato. E allora? Allora il sospetto è che alla base di tutto stia la spinta prima di tutto verso una sorta di purificazione di chiunque si approcci alla musica: esecutore, compositore o ascoltatore. Occorre lavorare su di sé prima come persone e poi come musicisti o cultori di musica. Nulla di simile a certe correnti alla moda che ogni tanto attraversano la società: qui si mette in campo una necessità ben precisa e urgente, quasi ovvia se si considera che quell’inestricabile mescolanza di razionalità ed emotività che è il lavoro musicale non può essere svolto al meglio con un carico di complessi e limiti autoimposti che gravano sulla persona. Allo stesso modo l’ascoltatore sarà così libero di cogliere in qualsiasi esecuzione ciò che meglio si adatta alla sua personalità, con apertura autentica e senza assurde pretese di completezza che soffocano la musica, la quale si fa un baffo della nostra artificiosa distinzione tra semplicità e complessità, analisi e spontaneità.
Diverse altre, ovviamente, sono le questioni affrontate nel libro: ad esempio il rapporto tra il compositore di oggi e gli strumenti tradizionali da una parte (ad esempio il contrabbasso, di cui parla Daniele Roccato, o il clavicembalo e il cimbalom dei quali parla Carla Magnan) e l’elettronica dall’altra, per non parlare di strumenti insoliti come il toy piano, che ha visto negli ultimi decenni una riscoperta (qui ne parla Federico Costanza, ma pensiamo alle opere di Cage o Kagel, o ancora a Matthew McConnell, Bernd Wiesemann e Yann Tiersen). Gli altri autori interpellati in Universi sonori sonoDenis Schuler (che parla soprattutto del ruolo della voce e delle percussioni nella sua musica), Daniele Corsi (che affronta l’interessante questione degli “spazi” per la musica), Marcela Pavia (che discorre tra l’altro del concetto, antico ma sempre attuale, di “varietà nell’unità”), Paolo Cavallone (che insiste sul necessario confronto con i grandi del passato e sulla difficoltà di scrivere per uno strumento storicizzato come il pianoforte). Presente nel volume anche una conversazione-ricordo con Landa Ketoff, critico e moglie dell’inventore del Synket.
Insieme a quelle con alcuni più o meno giovani musicisti che meriterebbero maggior visibilità, in Universi sonori ci sono anche due conversazioni con personaggi di grande notorietà: Ennio Morricone e Giorgio Gaslini. Il primo, notissimo per le sue colonne sonore ma anche autore di quella che lui chiama “musica assoluta”, ossia musica da concerto, ripercorre alcuni momenti salienti della sua carriera soffermandosi soprattutto sugli inizi come trombettista e studente di composizione nella classe di Petrassi (e la sua avventura a Darmstadt, dove negli intervalli tra un corso e l’altro organizzò una sorta di concerto per fischi e pernacchie ognuno dei quali inteso come “suono puro”). Il secondo, straordinario esempio di musicista poliedrico (anch’egli autore di nota musica per film ma anche pioniere del jazz, musicista classico e sperimentale), ripercorre soprattutto i suoi difficili rapporti di musicista aperto a varie influenze con la società italiana e con le avanguardie, oltre ad esporre le sue opinioni sulla delicata questione del rapporto tra musica e testo.
Un utile lavoro, quello di Longo e Nardacci (ambedue pianiste oltre che attente alle questioni teoriche), dal quale traspare l’urgenza di ridiscutere il nostro rapporto con la musica, nonché (mi pare fondamentale) la necessità di ripensare il compito di chi la musica la fa e la ama, e i suoi doveri nei confronti di chi potrebbe amarla ma non viene messo in condizione di conoscerla.
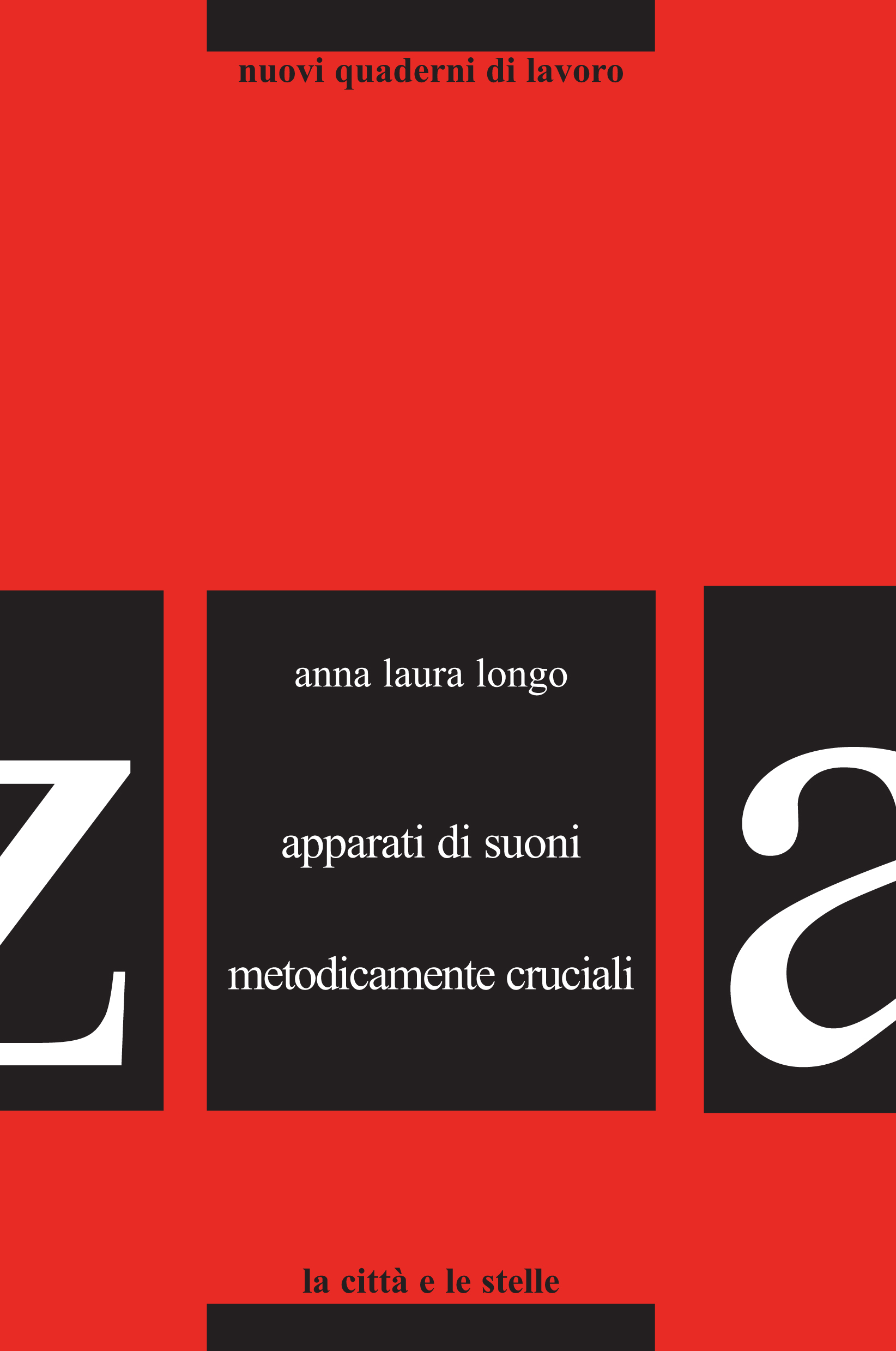 È necessario a questo proposito citare anche un altro lavoro di Anna Laura Longo: Apparati di suoni metodicamente cruciali. Il volume si presenta come una serie di recensioni, e talora di appunti (il termine non sembri riduttivo), scritte tra il 2010 e il 2012 a seguito della partecipazione a varie iniziative (concerti, performance…) tenute in tutta Europa, delle quali l’autrice cerca di cogliere e restituire a parole l’intima essenza (non va d’altra parte dimenticato che Longo è anche una valente poetessa). Come recita l’introduzione, scopo del volume è «fornire uno spaccato di quelli che sono gli scenari ed i territori di “accensione e tumulto” dell’arte musicale nel tempo presente», con una particolare attenzione a «quegli imprevedibili spiragli grazie a cui matura il germe dei nuovi linguaggi». Dal libro traspare la passione dell’autrice, che sa tenere a bada quell’incedere un po’ fanatico che le passioni troppo spesso messe a dura prova dalla quotidianità possono facilmente ispirare. Un forte accento, anche qui, è posto sulla necessità di «coltivare un’assidua e magari gioiosa insistenza nel disporsi in ascolto, con lo scopo di agire fondamentalmente sulla propria mentalità», affinché diventi «eclettica e non cristallizzata». Non sfuggano, qua e là tra gli scritti, alcune ben scelte citazioni che arricchiscono il discorso e contribuiscono a tracciarne le coordinate (tra le altre non sfugga quella da Agamben sul tempo della contemporaneità). E non sfugga come a tratti Longo parla del concerto come “esperienza” (e non solo nel caso di un’opera originalissima come Vexations, di un autore fondamentale come Satie), o come ritorni su un «cercatore intrepido» come John Cage, nonché l’attenzione per la danza o la musica di Morton Feldman. Appare dunque evidente il legame con il capitolo su François Delalande e la sua “didattica del risveglio”, autore del quale viene anche riportata questa citazione che con nettezza inquadra il problema: «si rischia di mettere il carro avanti ai buoi se non si crea, preliminarmente, un autentico appetito di musica; il desiderio di farla e di ascoltarla».
È necessario a questo proposito citare anche un altro lavoro di Anna Laura Longo: Apparati di suoni metodicamente cruciali. Il volume si presenta come una serie di recensioni, e talora di appunti (il termine non sembri riduttivo), scritte tra il 2010 e il 2012 a seguito della partecipazione a varie iniziative (concerti, performance…) tenute in tutta Europa, delle quali l’autrice cerca di cogliere e restituire a parole l’intima essenza (non va d’altra parte dimenticato che Longo è anche una valente poetessa). Come recita l’introduzione, scopo del volume è «fornire uno spaccato di quelli che sono gli scenari ed i territori di “accensione e tumulto” dell’arte musicale nel tempo presente», con una particolare attenzione a «quegli imprevedibili spiragli grazie a cui matura il germe dei nuovi linguaggi». Dal libro traspare la passione dell’autrice, che sa tenere a bada quell’incedere un po’ fanatico che le passioni troppo spesso messe a dura prova dalla quotidianità possono facilmente ispirare. Un forte accento, anche qui, è posto sulla necessità di «coltivare un’assidua e magari gioiosa insistenza nel disporsi in ascolto, con lo scopo di agire fondamentalmente sulla propria mentalità», affinché diventi «eclettica e non cristallizzata». Non sfuggano, qua e là tra gli scritti, alcune ben scelte citazioni che arricchiscono il discorso e contribuiscono a tracciarne le coordinate (tra le altre non sfugga quella da Agamben sul tempo della contemporaneità). E non sfugga come a tratti Longo parla del concerto come “esperienza” (e non solo nel caso di un’opera originalissima come Vexations, di un autore fondamentale come Satie), o come ritorni su un «cercatore intrepido» come John Cage, nonché l’attenzione per la danza o la musica di Morton Feldman. Appare dunque evidente il legame con il capitolo su François Delalande e la sua “didattica del risveglio”, autore del quale viene anche riportata questa citazione che con nettezza inquadra il problema: «si rischia di mettere il carro avanti ai buoi se non si crea, preliminarmente, un autentico appetito di musica; il desiderio di farla e di ascoltarla».
Sandro Montalto
Sandro Montalto

Lascia un commento