Scrittura e narrazione mitica nell’elaborazione del lutto d’amore: Fuochi di Marguerite Yourcenar
Ho ritrovato il vero senso delle metafore dei poeti.
Mi sveglio ogni notte nell’incendio del mio stesso sangue.
Questo libro non è stato scritto per essere letto. Nell’orizzonte della scrittura di Fuochi non c’è destinatario. In un’epoca di pornografia sentimentale dove il lutto va in scena, si fa o-sceno perché esposto come sopra il banco d’una macelleria, l’intimità d’un dolore che esula dal compiacimento esibizionista colpisce per l’audacia singolare della proposta, per il candore feroce dell’autoanalisi, per la consapevolezza ieratica di un’opera di volontaria eviscerazione. Il passaggio – nolente: “Spero che questo libro non venga mai letto” – dal privato al pubblico dà luogo piuttosto a un’oscenità altra. Oscena è la ferita dell’autrice perché parla di noi. Osceno è il sentimento che divora l’amante perché ha divorato, almeno una volta, anche noi. Osceno è l’amor(t)e perché pure noi, come Marguerite, ci siamo dibattuti nelle sue spire. “Un cuore, una cosa piuttosto sudicia”.
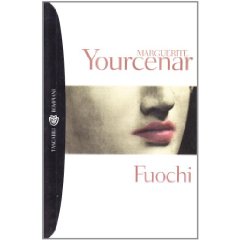 Amor fou, amore puro, amore totalizzante; se sei tutto, se sei parte di me, se non c’è scampo perché “tu riempi il mondo” e io “non posso fuggire che in te stesso”, la tua scomparsa è amputazione. Il trauma della separazione giganteggia fino a occludere il campo visivo, la dimensione della razionalità, l’istinto di autoconservazione. Tutto ciò che non sia (con) l’oggetto amato non ha (diritto di) esistenza. Perché si possa sopravvivere, l’elaborazione del lutto deve tradursi in impulso po(i)etico.
Amor fou, amore puro, amore totalizzante; se sei tutto, se sei parte di me, se non c’è scampo perché “tu riempi il mondo” e io “non posso fuggire che in te stesso”, la tua scomparsa è amputazione. Il trauma della separazione giganteggia fino a occludere il campo visivo, la dimensione della razionalità, l’istinto di autoconservazione. Tutto ciò che non sia (con) l’oggetto amato non ha (diritto di) esistenza. Perché si possa sopravvivere, l’elaborazione del lutto deve tradursi in impulso po(i)etico.
L’incendio informe della scrittura divampa in lacerti di diario che incastonano brevi racconti, rielaborazioni in chiave moderna di miti della classicità. Questa riscrittura è lo strumento maieutico indispensabile per partorire il dolore e dar inizio a una riflessione più alta su alcuni temi cardine del disfacimento d’amore: la Disperazione, la Menzogna, la Scelta e così via. È il luogo in cui appare massima la sovrapposizione del dato autoriale al dato universale, che a sua volta si particolarizza chiamando in causa la singolarità della nostra vita amorosa. Mito e attualità, esperienza individuale ed esperienza universale, passato e presente sono due specchi che, rifrangendosi, danno vita a chimere d’infinità, sparenti in una vertigine oscura. Il procedimento rivitalizzante dell’innestare elementi d’attualità sul palinsesto della narrazione mitica (la metropolitana, i caffè e i giradischi, i locali notturni d’Atene, il “cuore rivelatore” d’Antigone che richiama il racconto di Poe) produce un effetto di straniamento che favorisce la comprensione del messaggio mitico e assolve alla funzione di dichiararne la valenza universale e diacronica. Come per Lena, il segreto inconfessabile dell’autrice è l’ammissione di aver rinunciato a sé in presunto favore dell’altro, fino a “non darsi più”, che comunque “è darsi ancora. Significa dare il proprio sacrificio”. Lasciandosi rodere “dai vermi dei suoi ricordi” come Achille dopo la morte di Patroclo, “non uccide più” e dunque non ama più, non ama altri per non suscitare all’amato “rivali d’oltretomba”. Per bocca di Clitennestra, l’amante-autrice intavola un’arringa finale adducendo ragionevoli attenuanti all’uccisione dell’oggetto un tempo (ancora?) amato. Se non è possibile uccidere simbolicamente l’oggetto amato, la violenza si rivolta contro il soggetto amante. Saffo, acrobata en travesti di sterili talami, l’artista dagli occhi “presbiti del dolore”, tenta il suicidio per amore ma fallisce perché “chi non realizza la propria vita corre anche il rischio di fallire il suicidio”.
Scrittura del trauma, elegia della mutilazione d’amore, peana dello schianto di fantasmagorie fusionali, Fuochi è traversamento dell’Ade in cui abbandonare per sempre dietro di sé il tanto-amato, progressione di un’autoanalisi che sfrutta il calembour, il lapsus freudiano, l’associazione libera e sfrenata, la metafora, l’analogia. Lo stile esasperatamente enfatico, pletorico, definito nella prefazione autografa “espressionismo barocco”, si oppone alla discrezione oggettiva e oggettivante del noto stile yourcenariano e vira nella direzione di un manierismo teso alla totalità della poesia: solo l’esasperazione dei preziosismi può mettere a nudo l’essenza, ovvero i margini slabbrati, insanguinati d’una ferita mortale. La tortuosità lessicale e l’alto tasso di significazione sono il contraltare linguistico alla rovente temperatura dell’autocombustione amorosa.
Il lungo epicedio d’amore si scioglie tuttavia nel sarcasmo agrodolce della chiusa finale, che segue il tentato suicidio di Saffo: “Non mi ucciderò. Ci si scorda così presto dei morti”. La scrittura sa quindi essere strumento che rivela la cancrena del dolore, amputa l’arto senza vita, rimargina e cicatrizza la ferita. Dal grande falò di un amore, come araba fenice, è quindi sempre possibile risorgere: “Non si costruisce una felicità che su fondamenta di disperazione. Penso proprio che ora posso mettermi a costruire”.
Michela Pistidda

Lascia un commento