Siamo pensati più di quanto pensiamo: trascendenza dell’individuo e intelletto possibile.
Ciò che pensi non è tuo. O meglio, non ti appartiene allo stesso titolo in cui ti appartiene il tuo corpo. Il mio braccio rimane il mio braccio anche in una situazione di vuoto cosmico. Per quanto originale possa essere un mio pensiero, non è il mio genio che lo crea, come dal nulla, ma esiste solo in relazione a codici condivisi che ne costituiscono la condizione di possibilità. Se condividiamo l’idea per cui non c’è pensiero senza linguaggio (come potremmo infatti pensare senza parole?), dobbiamo riconoscere anche che non c’è pensiero senza comunità, poiché il linguaggio presuppone una relazione con l’altro – fosse anche tra me stesso in quanto me e me stesso in quanto altro.
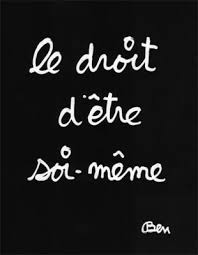 I miei pensieri appartengono alla comunità umana, che li crea nella misura in cui li rende possibili. Questo semplice pensiero, per l’appunto, faceva parte del senso comune, almeno fino al XVII secolo, quando la generalizzazione della società mercantile ha imposto una proprietà anche ai prodotti dell’intelletto. Prima tali prodotti immateriali erano appannaggio della sfera religiosa, la quale, per quanto criticabile sotto molti aspetti, garantiva almeno una protezione all’intelligenza, nella forma della separatezza. (Parlo naturalmente della Vecchia Europa, perché nelle Americhe prima dello sterminio, nella Grecia antica prima della romanità e in Oriente prima del New Age, il discorso era un po’ più complicato). Ovviamente, per evitare che questa sfera “intellettuale” venga spedita in un mondo ultraterreno e così in pratica neutralizzata, occorre rifiutare i dogmi escatologici, pur respirando l’atmosfera comunitaria che la religione fornisce. È stato così, dentro e contro il Cristianesimo, che un filosofo medievale, Averroè, è riuscito a pensare, forse nel modo più compiuto, un intelletto separato che rendeva possibile l’intellezione degli individui. Una sorta di intelligenza collettiva, che impediva ai singoli uomini di sentirsi artefici dei propri pensieri. Quasi una anticipazione di quello che Marx chiamerà General Intellect, un intelletto generale frutto dello sviluppo complessivo delle forze sociali.
I miei pensieri appartengono alla comunità umana, che li crea nella misura in cui li rende possibili. Questo semplice pensiero, per l’appunto, faceva parte del senso comune, almeno fino al XVII secolo, quando la generalizzazione della società mercantile ha imposto una proprietà anche ai prodotti dell’intelletto. Prima tali prodotti immateriali erano appannaggio della sfera religiosa, la quale, per quanto criticabile sotto molti aspetti, garantiva almeno una protezione all’intelligenza, nella forma della separatezza. (Parlo naturalmente della Vecchia Europa, perché nelle Americhe prima dello sterminio, nella Grecia antica prima della romanità e in Oriente prima del New Age, il discorso era un po’ più complicato). Ovviamente, per evitare che questa sfera “intellettuale” venga spedita in un mondo ultraterreno e così in pratica neutralizzata, occorre rifiutare i dogmi escatologici, pur respirando l’atmosfera comunitaria che la religione fornisce. È stato così, dentro e contro il Cristianesimo, che un filosofo medievale, Averroè, è riuscito a pensare, forse nel modo più compiuto, un intelletto separato che rendeva possibile l’intellezione degli individui. Una sorta di intelligenza collettiva, che impediva ai singoli uomini di sentirsi artefici dei propri pensieri. Quasi una anticipazione di quello che Marx chiamerà General Intellect, un intelletto generale frutto dello sviluppo complessivo delle forze sociali.
Il nostro spirito laico, che spesso è solo l’espressione gretta di una certa tristezza, sorride al pensiero che la Bibbia sia stata scritta da Dio. Eppure, astraendo dal dogma, rimane una bellissima metafora: un’opera collettiva, di un Intelletto sociale, che lungi dal potersi attribuire narcisisticamente a un uomo intellettualmente superdotato, era frutto del lavoro millenario della civiltà umana, o almeno di ciò che la civiltà rappresentava per una determinata comunità.
Oggi abbiamo perlopiù perso la capacità di pensare questa natura sociale dell’intelligenza e dei suoi prodotti. Brevettiamo tutto, anche i nostri pensieri. E persino in rete, mediocrissimi scribacchini, spezzatori di righi e prenditori di foto con smartphone, rivendicano con puntiglio il proprio diritto di autore per quelle che ritengono essere loro proprie creazioni. Mentre in realtà, ognuno di noi non fa altro che attingere a una sfera linguistica comune che ci sovrasta, di cui ci appropriamo piccoli pezzi, in proporzione alla nostra capacità, per vomitarli in forma di prodotti.
Anche dopo la generalizzazione della proprietà intellettuale, piccole isole di de-individualizzazione della produzione intellettuale sono emerse qua e là, sparute ed effimere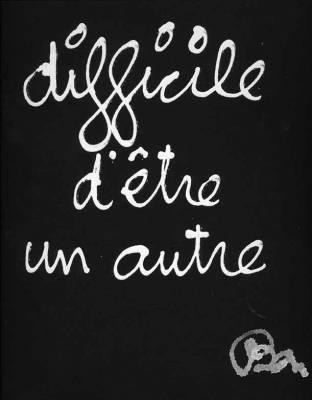 , piccoli atti di rivolta spesso sbeffeggiati e ridotti a posa intellettuale. Negli anni ’70 del ‘900, non erano pochi i “collettivi” che rifiutavano di apporre la firma ai “loro” prodotti. Opere d’arte, poesie, racconti e saggi erano ritenuti non solo patrimonio di tutti, ma prodotto di uno lavoro continuo, infinito nel tempo e nello spazio, cui partecipa l’umanità intera.
, piccoli atti di rivolta spesso sbeffeggiati e ridotti a posa intellettuale. Negli anni ’70 del ‘900, non erano pochi i “collettivi” che rifiutavano di apporre la firma ai “loro” prodotti. Opere d’arte, poesie, racconti e saggi erano ritenuti non solo patrimonio di tutti, ma prodotto di uno lavoro continuo, infinito nel tempo e nello spazio, cui partecipa l’umanità intera.
Nel nascondersi dietro un’identità fittizia c’è anche il riconoscere questa dimensione collettiva, profondamente umana, del lavoro intellettuale – che oggi, sia detto per inciso, si è generalizzato fino a divenire forma dominante della produzione tout court. È tristemente significativo che invece, nel ristretto ma enormemente meschino mondo accademico, sono oggi statisticamente irrilevanti gli “intellettuali” cui potrebbe saltare in mente di non apporre una firma ai propri lavori. Eppure, fino a qualche decennio fa, era diffusa la pratica dello pseudonimo, piccolo atto di devozione nei confronti di una causa che ci trascende in quanto individui.
Questa è la separatezza dell’intelletto che ci interessa: quella che riguarda la trascendenza della dimensione individuale, che sola permette di prendere parte al mondo, in altro modo, possibile.
Eva Di Giovanni

Lascia un commento