Quanto avvenuto a Parigi il 7 gennaio 2015 ha aperto lo spazio per una riflessione collettiva, che è auspicabile non si esaurisca nel tempo breve dell’emozione, servito finora solo da appoggio per la pronta adozione di nuove misure repressive, dall’alto, e per il ritorno in auge di identitarismi di varia natura, religiosi ed etnici, dal basso. Per contribuire ad approfondire il lavoro di critica di quello che sembra essere un evento dall’alto contenuto simbolico, ho ritenuto opportuno indagare il rapporto tra espressione artistica e prassi politica, ponendomi dal punto di vista del nesso che lega immaginario religioso e azione nel mondo, collocando quindi la mia analisi nella zona di intersezione tra la sfera 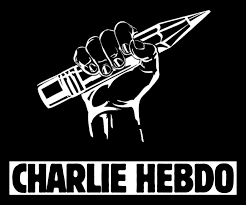 ultra-mondana e quella infra-mondana. Non è tanto in virtù dell’innegabile valore artistico dei testi sacri che fondano le istituzioni religiose contemporanee – e in particolare, quelle oggi più gravide di conseguenze politiche a livello mondiale: il Corano, l’Antico e Nuovo Testamento, possono essere letti come opere d’arte a pieno titolo – che questa operazione mi è parsa legittima. C’è una ragione più profonda, meno estrinseca alla problematica politica che ha mosso queste riflessioni: la religione forgia ancora oggi l’immaginario di enormi masse di individui, dando vita a un modo specifico di pensare e di sentire, di riflettere e di esperire. Il teatro religioso popolato da figure spirituali incarnate, non rimane confinato a una scena interiore onirica individuale, ma creando rappresentazioni del reale acquista un’esistenza mondana tanto estetica quanto etica. Le figure religiose rappresentano, benché in forma trasfigurata, i rapporti reali, il mondo vissuto così come viene immaginato, o più precisamente i rapporti immaginari tra l’individuo e le sue condizioni di esistenza; allo stesso tempo, tali figure retroagiscono nel mondo: è dentro e attraverso le rappresentazioni immaginarie dei rapporti reali che gli uomini vivono, riproducendo con le loro azioni nella realtà quelle condizioni sociali proiettate nella sfera del sacro in forma capovolta.
ultra-mondana e quella infra-mondana. Non è tanto in virtù dell’innegabile valore artistico dei testi sacri che fondano le istituzioni religiose contemporanee – e in particolare, quelle oggi più gravide di conseguenze politiche a livello mondiale: il Corano, l’Antico e Nuovo Testamento, possono essere letti come opere d’arte a pieno titolo – che questa operazione mi è parsa legittima. C’è una ragione più profonda, meno estrinseca alla problematica politica che ha mosso queste riflessioni: la religione forgia ancora oggi l’immaginario di enormi masse di individui, dando vita a un modo specifico di pensare e di sentire, di riflettere e di esperire. Il teatro religioso popolato da figure spirituali incarnate, non rimane confinato a una scena interiore onirica individuale, ma creando rappresentazioni del reale acquista un’esistenza mondana tanto estetica quanto etica. Le figure religiose rappresentano, benché in forma trasfigurata, i rapporti reali, il mondo vissuto così come viene immaginato, o più precisamente i rapporti immaginari tra l’individuo e le sue condizioni di esistenza; allo stesso tempo, tali figure retroagiscono nel mondo: è dentro e attraverso le rappresentazioni immaginarie dei rapporti reali che gli uomini vivono, riproducendo con le loro azioni nella realtà quelle condizioni sociali proiettate nella sfera del sacro in forma capovolta.
È altresì legittimo trovarsi in disaccordo con questo genere di interpretazione, che si pone deliberatamente fuori dal pensiero religioso. È tuttavia di una siffatta critica, che adotti cioè un punto di vista esterno al proprio oggetto, che mi pare si sia sentita l’esigenza nel dibattito attorno a Je suis Charlie. Al di là delle posizioni individuali, talvolta anche valide e interessanti, ritengo particolarmente significativa la polarizzazione del dibattito complessivo attorno a due affermazioni allo stesso modo parziali e fuorvianti riguardo all’origine dell’azione terroristica: da un lato, conseguenza del fanatismo religioso; dall’altro, espressione di istanze politiche. Occorre precisare che si tratta di una polarizzazione tendenziale: tra le due posizioni, troviamo un’infinità di sfumature; e l’una e l’altra sono state diversamente declinate così da dare vita a una considerevole varietà di interpretazioni. Ci si è divisi sul potere delle convinzioni religiose, su quanta parte di responsabilità fosse da attribuire alla religione in generale e quanta all’Islam in particolare; altri hanno insistito sul ruolo di copertura svolto dalla religione per interessi meramente politici; altri ancora hanno sostenuto che né la religione né la politica erano realmente in causa, ma solo l’accecamento individuale di chi ha commesso l’azione. C’è del vero in ognuna di queste affermazioni e infatti il loro limite consiste nel non aver colto il nesso tra i diversi termini, cioè il rapporto complesso tra esistenza reale degli individui, all’interno di condizioni storicamente determinate, e forme di espressione religiosa, che sono essenzialmente forme della coscienza, in vario grado immaginaria, di tali condizioni. Chiedersi quanto sia stato determinante ora l’Islam o il fanatismo, ora la politica o la follia criminale, non ci fa avanzare di un passo. Ma in che rapporto porre questi termini? Qual è il nesso che lega religione e politica, conoscenza e immaginazione, prassi nel mondo reale e sua proiezione in un mondo immaginario?
Ritengo che su questo tema possa ancora oggi venirci in soccorso la critica marxiana. Se oggi la posizione di Marx sulla religione ci appare del tutto irrecuperabile, è infatti solo per la sua riduzione, nel senso comune, a una sola celebre proposizione, che è generalmente interpretata in modo semplicistico e quindi erroneo: “la religione è l’oppio dei popoli”. Estrapolata dal contesto nel quale è formulata, questa affermazione è in effetti inutilizzabile per l’analisi di un evento tanto complesso come un atto terroristico compiuto in nome di un Dio. Quella che sembra essere una riduzione, rozza e sbrigativa, del valore umano e sociale della religione, rivela invece una posizione ben più complessa e feconda se ricollocata all’interno della Critica della filosofia del diritto di Hegel, che Marx redige nel 1843 e pubblica l’anno successivo nella rivista “Annali franco-tedeschi”. 
Innanzitutto, occorre leggere le affermazioni immediatamente precedenti: “La miseria religiosa è insieme l’espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimentodi un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo”.
La religione è quindi definita come sentimento, spirito e sospiro. L’oppio ha evidentemente un valore metaforico, da riferire all’uso, alla funzione cui la religione viene destinata. Il processo di costituzione della religione è invece legato alla sofferenza degli uomini per le condizioni materiali nelle quali sono gettati, al modo in cui sentono questa sofferenza, e infine all’espressione di questo sentire in forma trasfigurata. Il sentimento religioso è quindi l’atmosfera che gli uomini respirano nella loro sofferenza, della quale la proiezione nel sacro è anche manifestazione fantastica; ed è attraverso questa rappresentazione, a suo modo artistica, che gli uomini riproducono l’illusione di poter sfuggire alla realtà che è l’origine materiale delle fantasie spirituali.
Ora, se la causa reale dell’immaginario religioso è da ricercare nelle condizioni materiali, va da sé che solo la trasformazione del reale può portare all’emancipazione dall’uso consolatorio (l’oppio) della religione. Eppure, almeno in questo scritto giovanile, la critica della religione non viene liquidata come inefficace; le deve al contrario essere riconosciuta una funzione rivoluzionaria. La religione non è infatti puramente consolatoria, ma possiede, in quanto rappresentazione trasfigurata della reale sofferenza, un intrinseco potere critico di questo stesso reale. La “miseria religiosa”, scrive Marx, “è insieme l’espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale”. Un’arte contestatrice, verrebbe da dire forzando e aggiornando il testo marxiano, che è però nondimeno destinata ad essere superata in quanto è al contempo espressione capovolta del mondo, quindi in ultima analisi mistificazione dell’origine della sofferenza dell’uomo. La sua critica è per questa ragione necessaria. “Il fondamento della critica irreligiosa è: l’uomo fa la religione, e non la religione l’uomo. Infatti, la religione è la coscienza di sé e il sentimento di sé dell’uomo che non ha ancora conquistato o ha già di nuovo perduto se stesso. Ma l’uomo non è un essere astratto, posto fuori del mondo. L’uomo è il mondo dell’uomo, Stato, società. Questo Stato, questa società producono la religione, una coscienza capovolta del mondo, poiché essi sono un mondo capovolto. La religione è la teoria generale di questo mondo, il suo compendio enciclopedico, la sua logica in forma popolare, il suo point d’honneur spiritualistico, il suo entusiasmo, la sua sanzione morale, il suo solenne compimento, il suo universale fondamento di consolazione e di giustificazione. Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana non possiede una realtà vera. La lotta contro la religione è dunque mediatamente la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l’aroma spirituale”.
Ma gli effetti di protesta che la critica della religione genera, lungi dal rimanere sospesi nell’alto dei cieli, si dipanano nel mondo reale: “eliminare la religione in quanto illusoria felicità del popolo vuol dire esigerne la felicità reale. L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla sua condizione è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni. La critica della religione, dunque, è, in germe, la critica della valle di lacrime, di cui la religione è l’aureola”.
 Questo significa forse che il mondo liberato dalle condizioni materiali che generano sofferenza sarà un mondo che non avrà più bisogno di esprimere la propria spiritualità? Questa è la posizione che il senso comune attribuisce a Marx, riducendo il suo pensiero a una variante dell’ateismo materialista. Ma le cose, come stiamo mostrando, stanno diversamente: abbiamo visto che infatti l’esigenza spirituale non si può ridurre a quella che è la sua funzione consolatoria. È in gioco, nella religione, un’esigenza che appartiene all’uomo in quanto ente generico, quella di esprimere il proprio sentire in forme che potremmo definire artistiche. Ciò che occorre eliminare è infatti per Marx la radice materiale del dolore e non la fonte della realizzazione spirituale: “la critica ha strappato dalla catena i fiori immaginari, non perché l’uomo porti la catena spoglia e sconfortante, ma affinché egli getti via la catena e colga i fiori vivi”.
Questo significa forse che il mondo liberato dalle condizioni materiali che generano sofferenza sarà un mondo che non avrà più bisogno di esprimere la propria spiritualità? Questa è la posizione che il senso comune attribuisce a Marx, riducendo il suo pensiero a una variante dell’ateismo materialista. Ma le cose, come stiamo mostrando, stanno diversamente: abbiamo visto che infatti l’esigenza spirituale non si può ridurre a quella che è la sua funzione consolatoria. È in gioco, nella religione, un’esigenza che appartiene all’uomo in quanto ente generico, quella di esprimere il proprio sentire in forme che potremmo definire artistiche. Ciò che occorre eliminare è infatti per Marx la radice materiale del dolore e non la fonte della realizzazione spirituale: “la critica ha strappato dalla catena i fiori immaginari, non perché l’uomo porti la catena spoglia e sconfortante, ma affinché egli getti via la catena e colga i fiori vivi”.
Se la “critica del cielo” deve trasformarsi in “critica della terra”, la critica della religione in “critica del diritto”, la critica della teologia in “critica della politica”, non è per mettere al bando ogni forma di spiritualità, ma al contrario per liberarla e darle quel carattere pienamente umano che le è negato in una società fondata sullo sfruttamento, quindi sulla sofferenza.
Questo Marx, e non certo il semplice ateismo che gli si vuole spesso attribuire, può dirci qualcosa sulla strage del 7 gennaio. La critica dell’Islam deve essere solo critica delle condizioni materiali che sono alla base della sua nascita e della sua diffusione successiva, mai critica delle sue rappresentazioni in quanto espressione delle esigenze spirituali dell’uomo. La protesta che la religione veicola non cancella la sua funzione illusoria; di conseguenza la sua critica è certo un tassello della critica dell’attuale società. Non è tuttavia alla distruzione del sentimento religioso, né alle sue forme istituzionali e collettive, che occorre puntare; è al contrario alla sua liberazione che la critica deve lavorare. La critica dell’Islam non va da nessuna parte se non associata alla critica dell’esistente da cui trae origine, da un lato, e all’esaltazione del suo carattere di protesta e di espressione spirituale, dall’altro. Non è ai roghi di fiori che bisogna mirare, ma alla possibilità di cogliere finalmente i fiori vivi.
Maria Carla Trapani

Lascia un commento