Un frammento kafkiano posto in epigrafe dichiara l’illusorietà pervicace del reale: quando si strappa il velo di Maya, sotto di esso si scopre un altro velo di Maya. Da questo fertile spunto prendono le mosse le quattro novelle filosofiche di Gianni Celati, uscito per i tipi Mondadori nel 1987 e oggi edito da Feltrinelli.
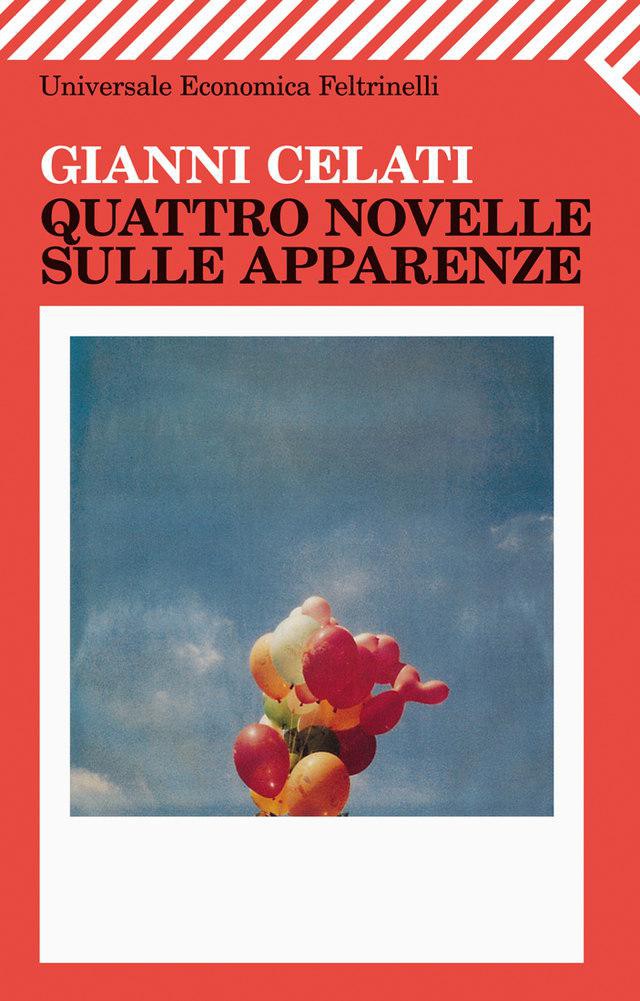 Nel primo e più significativo racconto il protagonista Baratto, docente di ginnastica con la passione per il rugby, smette tutto d’un tratto di parlare: il mutismo diviene la sua modalità di relazione col mondo. Come il nome pare suggerire, Baratto scambia “la farneticazione continua” con il silenzio. Va letteralmente in apnea linguistica. Abolendo la parvenza delle convenzioni, rappresentate per antonomasia dal linguaggio, il suo agire diventa puro significato. Da questo momento egli rimane aperto a un rapportarsi non mediato, privo delle insidie e delle finzioni della parola: è come le porte della sua casa, sempre aperte dal giorno in cui ha smesso di parlare. Ha cancellato anche il pensiero, diventando “un’ombra che passa senza darsi il pensiero d’essere un’ombra. Un apparire che è già uno scomparire. Come se niente in lui s’agitasse per comprovare qualcosa”. È appunto dalla necessità di comprovare qualcosa, a se stessi o agli altri, che è gravato l’individuo. Baratto, invece, “non si dà pensieri, né pensiero per i pensieri degli altri su di lui”, una condizione che taluni, ad esempio il preside della scuola, non esitano a definire “di grazia”.
Nel primo e più significativo racconto il protagonista Baratto, docente di ginnastica con la passione per il rugby, smette tutto d’un tratto di parlare: il mutismo diviene la sua modalità di relazione col mondo. Come il nome pare suggerire, Baratto scambia “la farneticazione continua” con il silenzio. Va letteralmente in apnea linguistica. Abolendo la parvenza delle convenzioni, rappresentate per antonomasia dal linguaggio, il suo agire diventa puro significato. Da questo momento egli rimane aperto a un rapportarsi non mediato, privo delle insidie e delle finzioni della parola: è come le porte della sua casa, sempre aperte dal giorno in cui ha smesso di parlare. Ha cancellato anche il pensiero, diventando “un’ombra che passa senza darsi il pensiero d’essere un’ombra. Un apparire che è già uno scomparire. Come se niente in lui s’agitasse per comprovare qualcosa”. È appunto dalla necessità di comprovare qualcosa, a se stessi o agli altri, che è gravato l’individuo. Baratto, invece, “non si dà pensieri, né pensiero per i pensieri degli altri su di lui”, una condizione che taluni, ad esempio il preside della scuola, non esitano a definire “di grazia”.
“Condizioni di luce sulla via Emilia” ruota attorno a una descrizione minuziosa della realtà attraverso gli occhi d’un pittore d’insegne, Menini, ossessionato dai processi di disfazione della luce. La rappresentazione scissa dei fenomeni luminosi richiama le forme frastagliate come fiammelle di vari pittori affetti da schizofrenia, da Séraphine de Senlins a Van Gogh passando per Louis Wain. Nulla è immobile, tutto ha confini labili, vacillanti. La concretezza del reale si fa intangibile e tremula sotto la luce cangiante, producendo un marasma sensoriale che oblitera i pensieri e invalida quindi la prima parte della locuzione cartesiana. Andando in vana ricerca dello “stato immobile delle cose”, Menini comprende che nell’incertezza del reale l’individuo è un disperso, un povero disgraziato. Di questa intuizione è appunto veicolo la luce, che “rende i corpi isolati nello spazio, mostra un loro isolamento definitivo, simile a quello d’un paracarro e d’un vaso di fiori” e dunque li reifica, allo scopo di renderli conformi a una vita dove ciò che non è una macchina, un oggetto, è una bassezza.
Il terzo racconto, “I lettori di libri sono sempre più falsi”, appare come il più dissacrante perché feroce critica dell’establishment culturale. Le vicende riguardano a un giovane studente di letteratura italiana che vuol imparare a “vantarsi d’aver capito benissimo i libri” come fanno i professori universitari. Benché trattati alla stregua di oggetti, di beni materiali oggetto di mercimonio tanto intellettuale quanto economico, i libri riaffermano la propria forza e s’impongono come rifugio e antidoto a un reale vacuo, che non si dice, quindi indecifrabile. Anche alla giovane Virginia, infatti, “è venuto in mente che tutte le frasi dei libri e dei giornali e delle insegne pubblicitarie avessero solo questo scopo: di evitare che quel muto apparire si presentasse, e allontanare l’imbarazzo che il suo pensiero procura”.
Il quarto e ultimo racconto, “Scomparsa di un uomo lodevole”, racconta la crisi esistenziale di un dirigente d’impresa. Padre di un figlio ottuso con il quale non comunica e per cui non prova alcun afflato di tenerezza, il protagonista giunge a capire di essere “uno qualsiasi, uno tra migliaia d’altri”. Dalla consapevolezza di essere nulla, perché “di io ce ne sono tanti in giro per il mondo”, nasce l’impossibilità di indicarsi, di definirsi, di dire “Io sono questo” e il mondo si riduce “ad un pugno di apparenze” che pongono “quest’unica domanda: Tu chi sei?”.
Dalla individuazione sconvolgente dello scarto tra realtà e illusione, che dirompe con l’immediatezza di una epifania, si ha la reazione nei confronti del mondo. Percependosi come frammento spurio, il protagonista prende le distanze da ogni convenzione sociale e rispetto alla consensualità acefala di una riduzione ad automa intraprende una scelta radicale, forse incomprensibile se analizzata con categorie razionali, ma perfettamente coerente con la rivelazione che ha dato luogo al trauma.
Tutto si dà come una sequenza di eventi di vita materiale, innescati come in un gioco del domino da un’iniziale tessera che fa crollare l’architettura dell’esperienza sensibile. Lo sconcerto di fondo che attanaglia il lettore, accostabile per intensità soltanto all’effetto di straniamento che è la cifra di Buzzati, nasce dalla meccanicità disvelata del nostro agire come individui imprigionati in una rete di vuoti schemi.
Nel mondo di queste novelle pare che l’amore, da intendersi nel senso più lato possibile, sia assente. I legami interpersonali appaiono come meri simulacri, simili alle squame disseccate d’una muta di rettile, pelle di cui i protagonisti dei racconti sono riusciti a liberarsi. Da qui si può ipotizzare che sia proprio l’amore a sorreggere il velo delle apparenze, a consentirci di vivere senza implodere nella vanità dell’esistenza, a mantenerci funzionali nell’avvicendare molteplici maschere sociali.
Una sottile vena ironica percorre sottotraccia i racconti, conferendo una nota ariosa alla drammatica assenza di senso postulata dall’autore. Tuttavia Celati non concede aperture salvifiche o soluzioni accomodanti: “tutto quello che si sa è che bisogna continuare, continuare, continuare come pellegrini nel mondo, fino al risveglio, se il risveglio verrà”.
Michela Pistidda

Lascia un commento